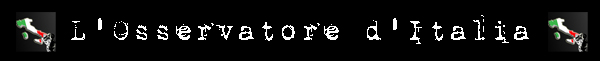Cronaca
Suicidio Marco Prato, Putignano: "il mistero della morte voluta e desiderata"
Tempo di lettura 5 minutiUn suicidio che sarebbe avvenuto per tutte le “menzogne dette” su di lui e per l’attenzione mediatica che ha subito
Published
8 anni faon

Tempo di lettura 5 minuti
di Angelo Barraco
In questi giorni si è parlato tanto del suicidio di Marco Prato, 31 anni, detenuto nel carcere di Velletri e accusato di aver massacrato, in data 4 marzo 2016, l’amico Luca Varani nel corso di un festino orgiastico a base di droga tenutosi nel quartiere Collatino. Prato era stato condannato a 30 anni con rito abbreviato e con lui anche Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni per il medesimo reato. Il giorno successivo avrebbe avuto l’udienza del processo. Un suicidio che sarebbe avvenuto per tutte le “menzogne dette” su di lui e per l’attenzione mediatica che ha subito. Ha lasciato inoltre una lettera in cui ha spiegato le ragioni del suo gesto. La Procura di Velletri ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio, procedimento coordinato dal Procuratore Prete e attualmente a carico di ignoti. L’indagine andrà a verificare se la sua detenzione fosse compatibile con le sue condizioni di salute psichica. Nella sua lettera d’addio scrive “Il suicidio non è né un atto di coraggio, né di codardia, il suicidio è una malattia dalla quale non sempre si guarisce”. Sono circa 15 i detenuti che si sono uccisi nei primi mesi del 2017; il 25 marzo un detenuto di 58 anni si è suicidato nel carcere di Rebibbia a Roma. La notizia è stata resa nota dalla trasmissione Radio Radicale RadioCarcere ed emerge che l’uomo si è tolto la vita tagliandosi la giugulare. L’uomo era in cella da solo e quella notte non ha dormito, preferendo al sonno una morte lenta e dolorosa. Il 25 maggio un detenuto di 43 anni, originario di Olbia, si è suicidato a Bancali (Sassari). La notizia è stata resa nota da Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell’Osapp che ha dichiarato all’Ansa che è“inaccettabile che simili criticità possano accadere in strutture nuove come quella di Sassari, in cui l'amministrazione penitenziaria ha investito molto in termini di risorse finanziarie, ma forse è arrivato il momento di investire sui quadri dirigenziali e direttivi. Facciamo appello al provveditore e al capo del Dipartimento perché valutino l'avvicendamento del direttore e del comandante del reparto”.
Napoleone Bonaparte disse “Chi si abbandona al dolore senza resistenza o si uccide per evitarlo abbandona il campo di battaglia prima di aver vinto”. Un pensiero certamente profondo quello di Napoleone perché analizza le ragioni che inducono l’uomo a desistere dinnanzi alla vita, ma certamente oggettvizza un gesto fortemente legato a dinamiche propriamente intime e soggettive, dove l’ombra delle ragioni di un addio rimangono perenni nella mente di chi non ha saputo cogliere le avvisaglie di una scelta che non lascia margine di ritorno. Sono molteplici i meccanismi che ruotano attorno alla complessa macchina chiamata ‘essere umano’, un complesso involucro di carne ed ossa che si muove all’interno di una realtà in continuo mutamento, che si confronta costantemente con i propri simili mediante intelletto e raziocinio e agisce secondo logiche consequenziali. Nel suo io più profondo, l’uomo coltiva costantemente un micro mondo fatto di elaborati pensieri e complesse realtà parallele dove implicitamente è in grado di creare scenari che possono anche distorcere la realtà tanto da estremizzarla e cambiarla in modo irreversibile. Il suicidio fa parte di quel processo di regressione interiore dell’essere umano che affiora nel momento in cui gli spiragli di luce sono così lontani da diventare invisibili -anche se ci sono ma si vedono poco- trasformando le pregresse zone di luce capiente in vere e proprie zone d’ombra dove si adagia silenziosamente l’anima in pena di chi non riesce ad aggrapparsi a nessuna alternativa di miglioria apparentemente possibile.
Noi de L’Osservatore D’Italia abbiamo parlato con la dottoressa Rossana Putignano [Psicologa- Psicoterapeuta, Consulente di parte con il CRIME ANALYSTS TEAM in qualità di Responsabile della Divisione Sud e della Divisione di Diagnosi Neuropsicologica e Forense]
Recentemente siamo rimasti sconvolti dalla notizia del suicidio di Marco Prato presso il Carcere di Velletri, ove era detenuto e in attesa del processo con rito ordinario, per la morte di Luca Varani. La modalità di suicidio (sacchetto di plastica e bomboletta del gas) ha lasciato tutti noi un po’ perplessi, come se il suicidio potesse essere una cosa standard, un fatto omologato. I suicidi sono bizzarri, teatrali, molto spesso anche finti ovvero possono essere inscenati in modo da allontanare tutti i sospetti e la cronaca nera di oggi è piena di questi casi.Anche la recente morte di Chriss Cornell, frontman degli Audioslave, ex Soundgarden, ha lasciato nello sgomento (e anche qualche dubbio!!!) migliaia di fans: in data 18 Maggio u.s. Cornell, dopo un concerto a Ditroit, si sarebbe impiccato con una fascia elastica nel bagno dell’Hotel presso il quale alloggiava. Il corpo è stato trovato per terra e non è dato sapere dove era assicurato questo cappio. Non siamo medici perciò, probabilemente, non conosceremo mai il mistero della morte voluta e desiderata, come avviene e da cosa e quali pensieri è preceduta. In qualità di psicologa forense direi che è necessario un quadro di depressione endogena o reattiva per poter scegliere la morte come unica soluzione alla propria sofferenza: insomma, occorre un disturbo dell’umore importante a meno che non vi è stato un uso di sostanze stupefacenti o di alcool in grado di alterare le proprie facoltà mentali. A differenza dei suicidi che occorrono altrove, all’interno del carcere essi acquistano un significato molto più profondo che hanno a che fare con la propria forza dell’Io, il coraggio di affrontare il processo e il giudizio, le speranze di rifarsi una vita dopo il carcere, la capacità di adattamento alla detenzione, assenza o presenza di pentimento ecc.. possono essere, dunque, tante le variabili che conducono il detenuto a scegliere di togliersi la vita. Marco Prato ha scelto di morire il giorno prima dell’inizio del suo processo, qualcosa avrà pur voluto comunicarci. Una cosa è certa: quando si sceglie di morire non vi è reparto psichiatrico o carcere che possa impedire all’individuo di tagliare i ponti con la vita. Di conseguenza, non vi dovrebbe essere responsabilità da parte del personale penitenziario (ndr. salvo negligenze accertate in fase di indagine preliminare o istigazione al suicidio). Lo ha stabilito recentemente il Ministro Orlando rispondendo alle interrogazioni di alcuni senatori in merito ai decessi di Youssef Mouhcine (24/04/2016) e Maurilio Pio Massimiliano Morabito (29/04/2016) all’interno della Casa Circondariale di Paola (CS). A detta della psicologa Youssef Mouhcine , arrestato il 5 marzo 2016, non aveva manifestato alcun segno psicopatologico che facesse presagire una ideazione anticonservativa, se non uno stato d’ansia e delle difficoltà relazionali. Non sono a conoscenza dei dettagli del suicidio di Prato, ma credo che Mouhcine è stato rinvenuto, più o meno, nelle medesime condizioni di Marco Prato, con la testa avvolta in una busta di plastica con all’interno il fornellino e la bomboletta del gas inserita. Maurilio Pio Massimiliano, invece, temeva che qualcuno potesse ucciderlo e per questa ragione fu collocato in una cella singola: è stato rinvenuto morto per impiccamento e non sono stati riscontrati elementi di responsabilità del personale addetto: il caso è stato archiviato. Nonostante l’affollamento delle carceri pare che la sorveglianza sia sempre garantita, così come il servizio di guardia medica. Il 3 Maggio 2016 il Ministro Orlando ha aumentato il monitoraggio del fenomeno adottando una direttiva sulla prevenzione dei suicidi nelle carceri, tuttavia, per esperienza clinica ritengo che sia veramente difficile arginare un fenomeno del genere, perché spesso, la volontà suicida è più forte della terapia psicofarmacologica. Alla luce delle mie stesse considerazioni, mi chiedo quale possa essere la vera forma di riabilitazione all’interno del carcere se non il pentimento e la consapevolezza di quel che si è fatto. A mio avviso, potrebbe essere utile un rafforzamento e una maggiore frequenza dei colloqui clinici con gli psicologi e psichiatri per una maggior consapevolezza di sé da parte del detenuto oppure la detenzione è talmente dolorosa da superare qualsiasi istinto di vita? Che poi, effettivamente, di quale vita parliamo se di limbo si tratta?
Continue Reading
You may like
Click to comment